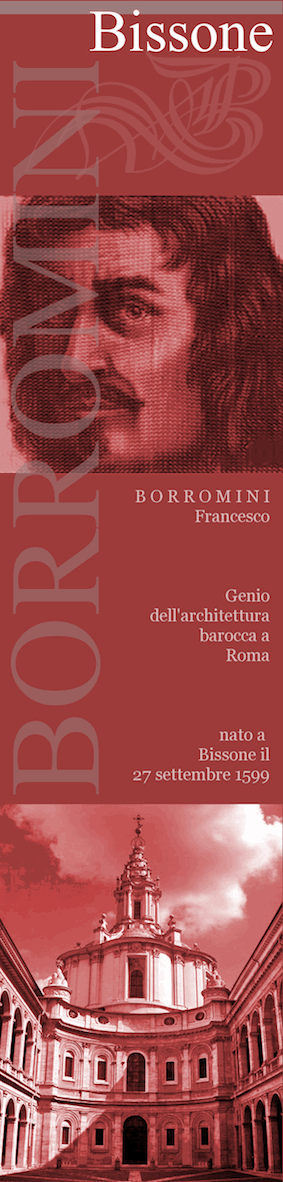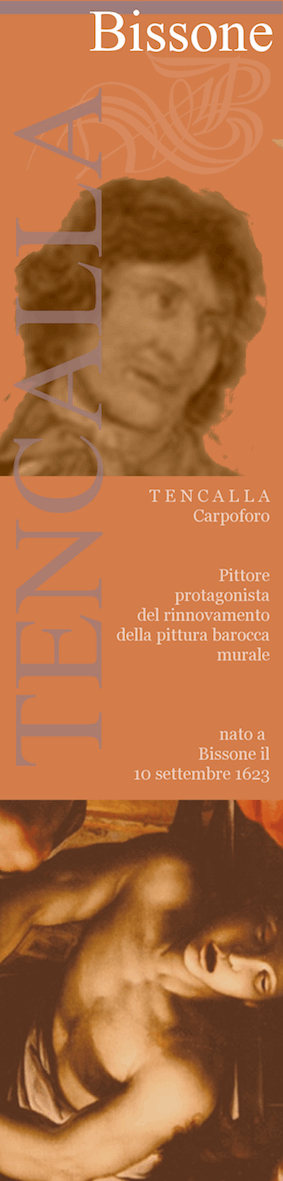L’insediamento attuale
Il vecchi o Bissone è leggibile in due insiemi. Preponderante importanza ha quello principale con un fronte porticato di prestigio verso strada e verso lago. Le contrade, gli stretti percorsi trasversali alla riva, uniscono strada cantonale e strada pedemontana. L’insieme minore comprendente chiesa e cimitero, conta pochi edifici. Mentre gli edifici di questo insieme poggiano in piano, un andamento in lievissima salita verso est/nordest caratterizza il nucleo principale. Lo spazio che individua e stacca le due parti dell’insediamento, utilizzato in parte a parcheggio, in parte occupato da edifici, su una mappa del 1854 appare progettato a parco.
o Bissone è leggibile in due insiemi. Preponderante importanza ha quello principale con un fronte porticato di prestigio verso strada e verso lago. Le contrade, gli stretti percorsi trasversali alla riva, uniscono strada cantonale e strada pedemontana. L’insieme minore comprendente chiesa e cimitero, conta pochi edifici. Mentre gli edifici di questo insieme poggiano in piano, un andamento in lievissima salita verso est/nordest caratterizza il nucleo principale. Lo spazio che individua e stacca le due parti dell’insediamento, utilizzato in parte a parcheggio, in parte occupato da edifici, su una mappa del 1854 appare progettato a parco.

Il disegno del nucleo abitativo mostra una simmetria e una coerenza e coesione spaziale eccezionali. A tale disegno contribuiscono, alle due estremità a nord e a sud, le due emergenze spazialmente equivalenti: l’oratorio di S.Rocco con l’albergo ristorante giustapposto e la Casa Tencalla con l’aggiunta seriore. I due elementi definiscono, con la quinta laterale del fronte porticato e la sottolineatura del lago, la piazza pubblica principale del villaggio, descritta dal Franscini, a metà del sec. XIX, come “ampia piazza ombreggiata da annosi tigli”.
L’oratorio di S.Rocco consiste di un’aula rettangolare absidata rivolta  a nord, con piccolo campanile, e conserva resti di pitture tardomedievali nella facciata e finestre termali.
a nord, con piccolo campanile, e conserva resti di pitture tardomedievali nella facciata e finestre termali.

La casa Tencalla ha verso il cortile acciottolato tre ordini di logge; sul retro é tutta aperta verso il lago, con la mediazione di una piccola spiaggia, con due ordini di loggiati ad archi e un terzo piano ad aperture rettangolari.
Un nuovo legame tra le rive del lago

Nel 1847 Bissone e Melide vengono collegate con il ponte diga (> 0.0.18), attraversato a partire dal 1874 anche dalla ferrovia. Tale legame influì fortemente sull’immagine e sul destino del villaggio: non più tappa importante, ma luogo di transito. Quale ulteriore mutamento, parte dell’ampia fascia tra fronte porticato e lago viene occupata dal tracciato della cantonale.

La Carta Siegfried mostra un piccolo agglomerato compatto affacciato sull’ampia riva a piazza e, distaccato, un nucleo minore. Tutto il pendio a monte e tutta la fascia lungolago fino a Campione appaiono coltivati a vite. Oltre al ponte diga, sono chiaramente leggibili la via pedemontana e la strada cantonale.
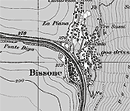 La Carta nazionale mostra inserimenti all’estremità settentrionale e a quella meridionale.
La Carta nazionale mostra inserimenti all’estremità settentrionale e a quella meridionale.
Il tracciato autostradale, aperto nel 1966 (> 0.0.17), fornì un più deciso stacco tra nucleo originario e quartieri residenziali della seconda metà del XX secolo ai piedi del Monte Borgnone (> III), sorti a scapito delle colture a vite.
Nascita ed evoluzione di un villaggio rinomato
Il nome del villaggio compare la prima volta in un documento longobardo del 735 come Blixuni, quale specificativo della provenienza di persone ivi citate. Al tempo era parte della Iudiciaria di Seprio – il futuro “Comitato” Franco – parte del Ducato longobardo di Milano.
Recenti studi sembrano dimostrare che il primo nucleo sia sorto a rispettosa distanza dal lago, in forma di doppio allineamento, a definire un percorso pedemontano, in stretta relazione con gli spazi coltivati – così le fonti altomedievali – a vite e a ulivo.

Il percorso generatore era parte del collegamento con Campione e, mediante attraversamento del lago, tra sud e nord Europa. La scelta del sito sarà stata favorita dalla facile accessibilità della riva e dal facile traghettamento in un punto in cui la distanza tra le due sponde era ridotta da una penisola morenica sul lato opposto.
Quasi certamente prima del Mille, all’estremità meridionale si era posta, a riprova dell’importanza dell’insediamento, la chiesa di S.Carpoforo , dipendente dal convento di S.Ambrogio di Milano. Per il 1054, nei pressi dell’edificio sacro è attestata la presenza di un edificio fortificato.

Durante tutto il basso Medioevo, il villaggio crebbe soprattutto verso lago, con la formazione di stecche trasversali alla riva e, quindi, agli allineamenti originari. Si andò configurando, in tal modo, un tessuto a pettine che ancora oggi caratterizza l’insediamento.
Probabilmente nel sec. XV si collocò l’oratorio di S. Rocco all’estremità nord del villaggio.
Il Santo dedicatario e l’epoca di rifacimento – il secolo XVII – collegano l’edificio all’evento della peste. Intanto, nel 1474, l’insediamento si era costituito in parrocchia autonoma staccandosi da Riva San Vitale. La progressione verso la riva e l’attestarsi di un fronte più ravvicinato al lago fu indotta, probabilmente, dalla crescita d’importanza della pesca. Bissone condivideva, infatti, con Melide e Morcote il privilegio dell’honor piscium: il diritto di pesca a pagamento e di approvvigionamento della città di Lugano. E’ inferibile che le case dei pescatori fossero dotate di parti coperte in legno per il riparo delle imbarcazioni e delle attrezzature per la pesca.
Tra tardo Medioevo e sec. XVII il fronte a lago è occupato dalle dimore delle famiglie borghesi, impreziosite da decorazioni. Il portico diventa elemento di continuazione tra edificio e edificio, vero e proprio luogo di transito, di sosta e di commercio al coperto. Uguali funzioni all’aperto ricopriva l’ampia piazza tra porticato e lago.

Il nucleo era protetto a est da un muro di cui rimane ancora testimonianza e nel quale si aprivano quattro porte: ancora fino a metà del secolo XIX, prima che venisse realizzata la strada cantonale, rappresentavano l’unico accesso via terra. Le porte sono oggi riconoscibili negli accessi orientali ad altrettante ‘contrade’, i percorsi trasversali alla riva.
 Intanto, una sorta di chiusura dello spazio antistante il fronte porticato venne dato a nord dall’Oratorio di S.Rocco, ingrandito e dotato di una facciata barocca nel 1630 circa – e a sud dalla casa Tencalla edificata durante il sec. XVII, probabilmente sull’originario sito di un castello . Ad ulteriore chiusura si giustapposero, sia all’oratorio sia alla Casa Tencalla, edifici già presenti nella mappa catastale del 1854.
Intanto, una sorta di chiusura dello spazio antistante il fronte porticato venne dato a nord dall’Oratorio di S.Rocco, ingrandito e dotato di una facciata barocca nel 1630 circa – e a sud dalla casa Tencalla edificata durante il sec. XVII, probabilmente sull’originario sito di un castello . Ad ulteriore chiusura si giustapposero, sia all’oratorio sia alla Casa Tencalla, edifici già presenti nella mappa catastale del 1854.
Il nucleo principale
 Il porticato descrive un movimento avvolgente il nucleo, apprezzabile alla vista da distanza. Dall’alto tale movimento informa fortemente il nucleo di un carattere di chiusura e compattezza. Gli archi, conclusi in modo vario – dall’arco ribassato a quello a sesto acuto – poggiano su colonne bombate in pietra e, soprattutto, su pilastri di mattoni. Verso sud il fronte aggetta leggermente e permette degli scorci eccezionali che amplificano le luci delle campate.
Il porticato descrive un movimento avvolgente il nucleo, apprezzabile alla vista da distanza. Dall’alto tale movimento informa fortemente il nucleo di un carattere di chiusura e compattezza. Gli archi, conclusi in modo vario – dall’arco ribassato a quello a sesto acuto – poggiano su colonne bombate in pietra e, soprattutto, su pilastri di mattoni. Verso sud il fronte aggetta leggermente e permette degli scorci eccezionali che amplificano le luci delle campate.
L’insieme della chiesa
 Nel nucleo minore, nonostante la posizione in piano, l’elegante mole della chiesa parrocchiale, sormontata dal campanile a copertura conica, assume su di sé la maggior parte del peso della relazione con il nucleo principale. Il ruolo di contropolo al nucleo abitativo che un tempo sosteneva da sola, oggi lo condivide con un edificio a corte, probabilmente esistente, con altra forma, già nel secolo XVII. A parte un certa concorrenza con la mole della chiesa, resa sensibile dall’elevazione fino a quattro piani, sottolinea con sensibilità l’andamento della strada cantonale.
Nel nucleo minore, nonostante la posizione in piano, l’elegante mole della chiesa parrocchiale, sormontata dal campanile a copertura conica, assume su di sé la maggior parte del peso della relazione con il nucleo principale. Il ruolo di contropolo al nucleo abitativo che un tempo sosteneva da sola, oggi lo condivide con un edificio a corte, probabilmente esistente, con altra forma, già nel secolo XVII. A parte un certa concorrenza con la mole della chiesa, resa sensibile dall’elevazione fino a quattro piani, sottolinea con sensibilità l’andamento della strada cantonale.